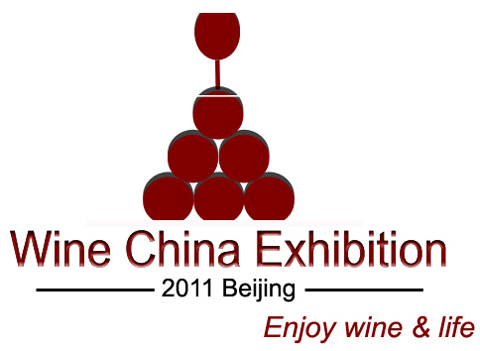Fa un po’ buffo parlarne proprio durante questa settimana delle Anteprime toscane quando tutti i produttori guatano con aria fintoindifferente, e nell’intimo speranzosa, tutti i communicators e buyers presenti con faccia e accento un po’ esotici. E fa buffo parlarne con la cautela che (a me) pare indispensabile dopo la diffusione piuttosto trionfalistica delle cifre sugli aumenti di export dei nostri vini. Ma le cose, penso io, stanno un po’ più come segue. E cioè, partendo dalle premesse…
Se con labboriggeno citato nel claim di questa rubrica, e rubato al mitico Guzzanti, non abbiamo forse ancora un tot da dirci, col Cinese in Coma (sfilato a Verdone), ma in coma da vino importato, e sempre più a rota di bocce fighe, avremmo invece da dirci molto. E se, anzi, non riusciremo a dircelo a tempo e bene, noi Vino d’Italia (perdonate l’immedesimazione, sarà l’effetto del 150.mo) finiremmo col pestare una torta di vacca bella grossa. Il Cinese di cui sopra è ovviamente il mercato cinese. Che sta marciando ancor più a schizzo di quanto si potesse un po’ d’anni fa, pur provandoci, immaginare (la ricchezza prodotta continua a salire a botte da due cifre, pur frenata per cautela da chi regge la barra). Ma il problema è che la nuova Eldorado dell’import sta coinvolgendo e assorbendo realmente solo una scheggia micro dell’eno-mondo italiano.
Shangai, padiglioni, fiere, governi, Regioni, buonitalie e Italie così-così, missioni Vinitaly e raid-show vari, e altro ancora (e ci limitiamo ai big) si sono succeduti e si stanno succedendo a ritmi sempre più fitti. E questo, a parte i molti soldi (pubblici per lo più, claro) spesi in passato in iniziative velleitarie e/o improvvisate, o in belle gite per club di assessori & dirigenti guidati in ordine sparso – e a concludere cippa – da ciceroni a loro volta molto interessati, è il segno che l’urgenza è percepita. Il che è quasi consolante. Ma, alla fine della fiera (o dell’Expò…) cosa pensa di noi (Vino d’Italia sempre) il Cinese in Coma? E, soprattutto, ci pensa?
Pochino, si direbbe, a giudicare da un paio di test in rete, condotti ad esempio sul sito a target internazionale più importante e visitato (è il primo in tutti i motori di ricerca che contano) dedicato alla cosa che ci sta a cuore. Due citazionucce appena, in un mare sterminato di cose & persone. Intervista short con Gaia Gaja (tanks Angelo’s family!, su ‘ste cose sempre avanti), per sapere qual è il suo rapporto di young Lady Wine con il mondo del consumo enoico cinese; e citazione di passata per la famiglia Antinori. Share stimato (percentuale sul numero totale dei wine people intervistati, nominati, censiti etc.) 0,01%. Ci vogliamo entusiasmare?
C’è poi il problema non tanto di share, e nemmeno di crescita bruta dell’export in quantità (il 100% di pochissimo, se si va un attimo oltre i numeri, è e resta quasi niente) ma del valore unitario per bottiglia. Quello è un test che fotografa abbastanza lo stato dell’arte, in un mondo in cui il consumo di vino straniero di target da medio in su in Cina riguarda anzitutto le nuove élite, ed è dunque orientato dal plusvalore di status symbol, prima e più che dal contenuto sensoriale della boccia. E lì risulta che siamo ancora abbastanza a trix. Il resto del popolo che beve, beve invece very low cost. E siamo di nuovo a trix, col Bordeaux profondo (oh yeah) proposto laggiù a 1,1 euro al pezzo!! Si tratta di un problema peraltro già vissuto (sottovalutandolo) nei due piccoli mercati spot asiatici che hanno fatto da apripista al boom cinese: Hong Kong e Singapore. A mangiarci in testa là, oltre ai soliti francesi, c’erano pure Usa e Aussie. Con la giustificazione accettabile che i primi sono di casa per via degli affari di petrolio (l’ecologicissima Singapore, dove la patente auto costa una cifra, devi cambiare la macchina per legge ogni pochissimi anni, e se sbatti contro un albero danneggiandolo lo paghi quasi quanto certa gente una dozzina di ruby, è in realtà la capitale dei conteiner di petrolio e relativa raffinazione), e gli australiani lì giocano e vendono nel cortile di casa.
Ma la battaglia cinese è altra roba; e la posta in gioco ben altra. Per renderci meglio conto di tutto, allora, serve un insider. Uno spiraglio da cui osservare qualcuno informato dei fatti. Uno/a che scriva e parli (in inglese) al, e del, mercato che aprimmo, pionieri, con Marco Polo e da allora o quasi, zero carbonella.
Una pista giusta in questo senso è ad esempio la signora Jeannie Cho Lee, reputata master of wine: la sua label MWine è un manuale da super sommelier in cui la lady (ascoltatissima) “detta” gli abbinamenti dei vini del mondo con i piatti di area, cioè con tutto il top di gamma della cucina asiatica. Coreana di stanza a Hong Kong, Jeannie parla anche ai nuovi gourmet della grande Cina. Sapere cosa viene consigliato, e con cosa, sul suo blog, è fondamentale per farsi un’idea. Di cosa e come proporre e vendere in zona.
Un altro aiuto arriverebbe di certo andando a visitare i “luoghi” web deputati di personaggi come Julia Zhu, reputata sommelier dell’Hilton Beijing, o più ancora di Ch’ng Poh Tiong, scrittore, editorialista, consulente, uomo del vino a tutto tondo, che scrive su fondamentali riviste anglosassoni, ma il cui blog personale è purtroppo redatto in cinese.
E’ angolofono invece per fortuna il sito delle interviste ai maggiori protagonisti dell’universo vino in tutto il mondo. Tocca, come sia, darsi una mossa. Perché loro, i nostri potenziali migliori clienti, se la stanno dando, eccome. Sia intensificando a tutta l’autoproduzione (si sentirà prresto parlare di vitigni più o meno autoctoni come la cosiddetta French Wild, o la Rose Honey, la prima arrivata in Asia attorno al 1950 e ormai “adattata” in Cina, ma anche in Vietnam, Indonesia o Thailandia, dove il signor Chaleo Yoovidhya, un super Paperone di lì, s’è buttato a corpo morto nel wine business, ha fatto piantare anche Syrah e Colombard su 240 ettari a sud di Bangkok, ha ingaggiato uno squadrone di enologi (segnatevi il nome del, diciamo così, Rolland di zona: Chaorai Kanchanomai) ed è dentro una filiera di capitali, la Red Bull, che unisce una collana di proprietà in Sudafrica, California (Vella), Australia (Kookaburra’s), Francia (Chateau Vendome in Languedoc e in Champagne l’Armand de Brignac). Mentre un commando del “public capital” cinese, la Cofco, che aveva già chiuso qualche tempo fa l’acquisto di uno Chateau, il Viaud, a Bordeaux, era ieri l’altro in Francia a brindare all’affare, ma soprattutto ad allacciare in loco un accordo di collaborazione per l’acquisizione di know how da applicare su entrambi i fronti produttivi: Francia e Cina. E anche su questo è il caso di farsi una domandina: come mai da noi non comprano nulla? Dobbiamo esserne contenti o scontenti? Dobbiamo, morettianamente, davvero pensare che ci si noterà di più se non partecipiamo alla festa?
Foto: chaxiubao